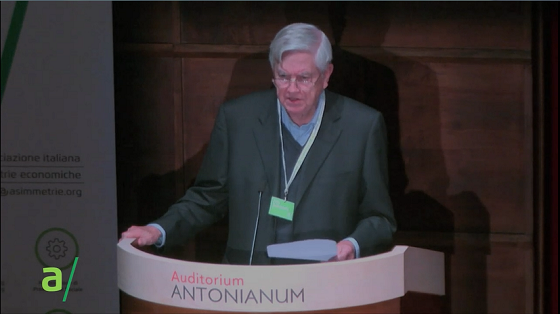L’idea di risolvere i conflitti interni di un paese ricorrendo ad aiuti esterni è tipica dei paesi in via di sviluppo, o di quelli di recente costruzione, o comunque poco coesi. Non è chiaro quanto questo metodo sia davvero utile allo sviluppo dei paesi, tuttavia con il progresso economico e sociale le caratteristiche che li rendono fragili tendono gradualmente ad attenuarsi di pari passo con il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della struttura produttiva. L’Italia è una nazione relativamente giovane, unita 150 anni fa quando ancora però c’erano da “fare gli italiani”. Passata attraverso due guerre mondiali, prende forma come Repubblica solo 70 anni fa. L’Italia repubblicana ha sempre conosciuto una qualche forma di vincolo esterno, a cominciare da una fase iniziale di relativa prosperità, guidata dalla ricostruzione post bellica sostenuta dagli Stati Uniti. Con la fine del sistema di Bretton Woods, l’Italia cerca di ritrovare un aggancio esterno, prima con il sistema monetario europeo e poi – dopo il suo fallimento – con l’unione monetaria europea. Questi vincoli diventano sempre più stringenti, poiché la liberalizzazione dei movimenti di capitali, assieme alla rigidità del cambio, alla perdita della politica monetaria e ai limiti alla politica fiscale, limiteranno fortemente la capacità di condurre le politiche macroeconomiche a livello nazionale.
Il vincolo esterno
Verso la fine degli anni ’70, l’ex-governatore della Banca d’Italia Guido Carli professa tutto il suo pessimismo rispetto alla qualità della classe politica italiana e alla sua capacità di guidare il paese in uno spirito di modernità e riformismo, richiesto dal funzionamento di un’economia di mercato.
Successivamente scriverà: “La nostra scelta del ‘vincolo esterno’ nasce sul ceppo di un pessimismo basato sulla convinzione che gli istinti animali della società italiana, lasciati al loro naturale sviluppo, avrebbero portato altrove questo Paese”. (Guido Carli, Cinquant’anni di vita italiana).
In particolare, il controllo della politica monetaria, resa prima indipendente da quella fiscale e in seguito addirittura ceduta a un’entità sovranazionale difficilmente controllabile da qualsiasi governo, poteva definitivamente risolvere il conflitto interno, vincendo le resistenze di chi a sinistra voleva mantenere un ruolo importante dello stato nell’economia. Il vincolo esterno consentiva di indebolire i governi, spingendoli a prendere decisioni impopolari: non avendo più la politica monetaria a disposizione, ogni aggiustamento doveva essere necessariamente realizzato attraverso svalutazione interna di prezzi e salari, con buona pace dei sindacati, dei movimenti operai, dei rappresentanti politici del mondo del lavoro; la proibizione per la banca centrale di garantire il debito pubblico, metteva sotto pressione anche la politica fiscale; l’unica leva a disposizione rimaneva una politica dei redditi destinata ad assorbire tutti gli squilibri macroeconomici. Non tutti gli intellettuali dell’epoca sottoscrissero questa visione, si pensi ai dubbi di Federico Caffè in merito, e nemmeno tutti i partiti politici, si pensi alle posizioni del PCI fino al 1978 in merito all’adesione al sistema monetario europeo. Tuttavia pezzi fondamentali di classe dirigente italiana sposarono appieno la linea di Carli e si adoperarono per realizzarla.
Il primo e più convinto sostenitore delle virtù del vincolo esterno nel disciplinare partiti, sindacati e amministrazioni pubbliche italiane fu Carlo Azeglio Ciampi. Di fatti il primo e più importante passo fu il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’Italia, realizzato nel 1981 da un gruppo di tecnici, guidati da Ciampi per la Banca d’Italia e da Beniamino Andreatta per il Ministero del Tesoro, senza passare per alcun dibattito parlamentare. La portata storica di quella decisone è facilmente intuibile: da quel momento in poi la Banca d’Italia toglieva la garanzia del collocamento integrale dei titoli di stato, cioè eliminava la possibilità di calmierare i tassi d’interesse che il mercato poteva richiedere allo stato per rifinanziare il suo debito, di fatto mettendo lo stato in mano al mercato. “Un importante progresso” lo definì Ciampi nelle sue considerazioni finali di quell’anno, perché:”solo arrestando il degrado monetario si può ottenere un durevole ritorno dei privati sui titoli a lunga e ottemperare al dettato della tutela del risparmio” (p.896).
Vale la pena ricordare che in quel momento il debito pubblico italiano era basso, che esso aumentò vertiginosamente nel decennio successivo, e soprattutto che la maggior parte dell’aumento non fu dovuto alla spesa corrente ma alla spesa per interessi. In altre parole, dal 1981 lo Stato fu vincolato al ricatto del mercato, che poté limitarne da lì in poi il margine di manovra. Inoltre le politiche monetarie della Banca d’Italia furono orientate al mantenimento della parità di cambio imposta dal sistema monetario europeo, piuttosto che a considerazioni di equilibrio economico interno.
Spesa primaria (esclusi interessi sul debito) e spesa totale in % al PIL
 Fonte: Fondazione Robert Schuman, dati Banca d’Italia.
Fonte: Fondazione Robert Schuman, dati Banca d’Italia.
Il secondo passo fondamentale del “vincolismo” fu l’adesione a un sistema monetario sovranazionale, che vincolasse anche la politica monetaria già indipendente della Banca d’Italia. Il sistema monetario europeo era l’anticamera del progetto di unificazione monetaria; la firma del Trattato di Maastricht, il cui negoziato per l’Italia fu condotto dallo stesso Carli, rappresentò poi il sigillo alla costruzione del vincolo esterno. La mobilità dei capitali, la perdita della leva di politica monetaria, la proibizione di trasferimenti, l’assenza di un bilancio comune e di qualsiasi meccanismo di stabilizzazione automatica, e i vincoli asimmetrici alla politica fiscale nazionale, configuravano un potentissimo vincolo esterno di impronta neoliberista, che non avrebbe più permesso ad alcun governo di sfuggire all’agenda politica ed economica dominante: pressione sulla sostenibilità del debito pubblico, quindi dismissioni del patrimonio pubblico e privatizzazioni, svalutazione del lavoro e compressione salariale, aumento del credito (debito) per compensare la domanda interna, e finanziarizzazione dell’economia. Tale agenda dominante fu un consenso maturato fra le élites tecnocratiche, che contribuì all’affievolimento del potere di controllo democratico e a una vera e propria “de-democratizzazione” nei paesi che vi aderirono.
L’idea di fondo era che le tensioni redistributive interne fra capitale e lavoro potessero sostanzialmente risolversi vincolando la politica monetaria e scaricando sulla svalutazione del lavoro il peso di ogni aggiustamento macroeconomico. Inoltre, il nuovo consenso stabiliva l’inefficacia degli stimoli della politica fiscale, indipendentemente dalla situazione congiunturale del ciclo economico. È paradossale che le teorie sulle quali queste convinzioni si basavano considerassero i cittadini allo stesso tempo come degli individui perfettamente informati e razionali da scontare in anticipo gli effetti futuri sulla tassazione di un’espansione fiscale presente, ma anche degli individui completamente incapaci di scegliersi un governo e una politica economica adeguata, attraverso un processo elettorale. In questo paradosso si riassume la contraddizione interna del modello teorico al quale l’Italia si stava vincolando.
La classe dirigente
Il PCI, che pure aveva maturato al suo interno una riflessione acuta e profonda sui rischi dell’adesione al sistema monetario europeo (si pensi ai discorsi di Spaventa, Barca, e Napolitano), cambiò bruscamente rotta alla fine del 1978. Sarà interessante per gli storici andare a studiare cosa esattamente accadde in quei mesi, successivi all’assassinio Moro, in cui la dirigenza del più grande partito comunista d’occidente accettò di fatto le linee programmatiche di politica macroeconomica del grande capitale, con l’obiettivo di diventare “credibile” come forza di governo. Lo diventerà, poi, forza di governo, nel mondo post-comunista, nella cosiddetta “seconda Repubblica”, nelle sue nuove varie forme (PDS, DS, PD), anche se non è forse un caso che non riuscirà mai a trovare fra le sue fila ed esprimere una personalità in grado di gestire il Ministero più importante per l’indirizzo di politica economica, quello dell’economia e delle finanze, dovendo sempre appaltare a “tecnici” e “indipendenti” la gestione della politica economica, da Ciampi fino a Padoan.
Inizialmente poteva forse esserci un po’ di pudore, nel trovarsi ad applicare politiche deflazionistiche di svalutazione interna, attraverso moderazione salariale, e di limitazione del ruolo dello stato, attraverso privatizzazioni su larga scala dei servizi pubblici più importanti. In seguito divenne chiaro come si trattasse anche di palese inadeguatezza, mancando nella classe politica PDS-DS-PD le competenze tecniche essenziali per la gestione economica di un paese. Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Romano Prodi, Tommaso Padoa-Schioppa, furono tutti tecnocrati, indipendenti, molto “credibili” in quanto alla loro adesione al consenso neoliberista che sembrava dominare il mondo. Per questo furono subito erti a paladini della nuova “sinistra”, che per governare era disposta a fare ciò che un tempo rimproverava alla destra. I governi di centro-sinistra sposarono in pieno i dettami imposti dal vincolo esterno: la riforma del lavoro, che iniziava il lungo processo di svalutazione interna introducendo precarietà e moderazione salariale, fu opera del Governo Prodi; le privatizzazioni (le più grandi realizzate in un paese europeo) furono opera dei Governi Amato, Prodi, e D’Alema, tutte gestite dal potente Direttore Generale del Tesoro, Mario Draghi.
Il centro-destra durante tutta la cosiddetta “seconda Repubblica” rimase prigioniero del sistema di interessi personali del suo leader, Silvio Berlusconi, che sembrava più interessato ad aggirare i vincoli, esterni come interni, cercando per lo più vantaggi per sé e per le proprie aziende, piuttosto che a proporre una vera alternativa. La classe politica del centro-sinistra, invece, ha sempre diligentemente dato il suo appoggio politico alla linea economica imposta dal vincolo esterno, lasciandola gestire da “tecnici”, cosiddetti “indipendenti”. Si arriva così all’appoggio a Mario Monti e alla dottrina dei giovani parvenus à la Renzi, secondo cui “le riforme le facciamo perché vogliamo noi e non perché ce le chiede l’Europa”. Poco importa che esse siano esattamente quelle imposte dal vincolo esterno.
Verso una maturazione
L’ostacolo principale per un’uscita dell’Italia dai vincoli esterni sarà quello di creare una classe politica all’altezza, capace non più di fare da “passacarte” delle burocrazie internazionali, ma di ricostruire e guidare un paese, per la prima volta pienamente autonomo e responsabile del proprio destino. Vorrebbe dire avere una classe dirigente capace di trattare alla pari con le principali diplomazie mondiali e con le burocrazie internazionali. Vorrebbe dire saper ponderare ogni scelta politica, prevederne le conseguenze e anticipare le reazioni degli altri. In altre parole, saper stare sulle proprie gambe. Questo era proprio il motivo di pessimismo che spingeva Carli quarant’anni fa a ritenere che, a differenza di paesi “maturi” come la Francia, l’Italia avesse invece bisogno di essere affidata al vincolo esterno.
Questa nazione relativamente giovane è stata legata mani e piedi a un vincolo esterno progressivamente più stringente, che nel bene e nel male ne ha condizionato la storia durante gli ultimi decenni. Si può argomentare che in fondo fossero valide le ragioni di quei “vincolisti” che decisero di limitare drasticamente l’autonomia e la sovranità politica nazionale nei decenni a venire, in quanto scettici riguardo le capacità della classe politica nazionale di operare per il bene del paese. Infatti gli ultimi a prendere una decisione vitale per il futuro del paese e che ne avrebbe condizionato l’esistenza per molti decenni a venire furono proprio loro, con i risultati fallimentari che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Quella sfiducia di fondo nella classe politica nazionale, quindi, potrebbe essere letta come una auto-sfiducia nelle proprie capacità. Senz’altro giustificata, col senno di poi.
Le ragioni dei “vincolisti” potranno essere smentite solo quando arriverà una nuova classe dirigente italiana, che avrà il compito di superare l’affidamento al quale il paese è stato consegnato in questa sua fase adolescenziale, per permettergli di camminare sulle proprie gambe e per evitare di frustrarne la vita da adulto. Il conflitto di classe interno, che ha caratterizzato la storia economica dell’Italia, va oggi progressivamente sfumando, man mano che tutto il paese scivola in una stagnazione e in un impoverimento senza fine. Quando questo processo sarà fermato, probabilmente con grandi costi e sacrifici, sarà importante trarre una lezione anche dalla fase che stiamo vivendo: il conflitto distributivo interno non dovrà più invocare il ricorso ad aiuti esterni, nella forma di vincoli che penalizzino una parte del paese, anche se è la parte avversa.
Il rischio è che, una volta messo il destino del paese in mani esterne, poi non si possa più tornare indietro, quando si prende atto che l’impoverimento e la sconfitta di una parte (il lavoro) finisce per trascinare con sé anche l’altra (il capitale).
Agenor